Ricordo vent’anni fa quando lavoravo per uno dei primi programmi di traduzione automatica in commercio.
L’archetipo di Google Translate, tanto per capirci.
Ero a Barcellona, una città cosmopolita che attirava tra le sue braccia festaiole un miscuglio di artisti, professionisti rampanti e frenetici addii al celibato.
L’obiettivo del programma era sviluppare una grammatica per tonti.
Le macchine non ragionano con gli stessi parametri contestuali del cervello umano: vanno pungolate, messe alle strette con regole binarie, con scelte o rinunce incontrovertibili.
O la parola “fly” si traduce con “volare” oppure si traduce con “mosca”. E guai a trovare una mosca che vola, si manda in tilt il sistema. In preda a una crisi di panico, il suo cervello matematico scoverebbe la terza opzione di traduzione: “la cerniera dei pantaloni”. Una mosca che vola con la cerniera dei pantaloni calata.
Un abominio della natura.
Linguisti e programmatori dovevano lavorare a braccetto, cercando di capirsi gli uni con gli altri. Poi c’era la famigerata categoria dei “grammar developer” di cui io facevo parte. L’ibrido.
Un linguista che si travestiva da computer, ne assumeva l’aria grigia, la postura contratta da parallelepipedo. Comunicava persino in linguaggio informatico, utilizzando un codice di costanti e variabili.
Era senza dubbio un compito contro natura, come unire due magneti con poli opposti. Ma anche una sfida. L’intelligenza artificiale era agli albori, le premesse parevano promettenti.
Dopo la traduzione automatica, ci aspettavamo un robot che ci servisse il caffè e ci lavasse i calzini, uno con cui sfogarci sulle storie amorose naufragate e uno che finalmente ci spiegasse perché il cibo più buono fa ingrassare.
Gli sviluppatori di grammatica erano teoricamente assunti col compito di comandare. Dovevano “istruire” la macchina, piegarla al loro volere. Mostrarle l’incanto di un complemento oggetto, lusingarla a forza di passivi e preposizioni articolate.
Ci avevano detto che le lingue galleggiavano sopra strutture universali, come placche tettoniche su un unico magma. Bastava individuare il magma, scomporlo nelle sue parti fondamentali e rimettere insieme i pezzettini.
La realtà però era ben diversa. Diventavamo umanoidi frustrati, in bilico tra due mondi.
Erudire un programma era come guidare un ubriaco in una bufera di neve. Bisognava sorreggerlo, figurarsi dove poteva cascare, anticipare gli scivoloni con cuscinetti elaborati ad arte. Immaginare, ad esempio, che il povero George Bush, senza qualche accorgimento, poteva diventare non solo Giorgio Cespuglio ma persino Giorgio Pelo Pubico. I fraintendimenti partivano dalle singole parole e si ampliavano a dismisura nei trabocchetti della sintassi, creando effetti domino potenzialmente catastrofici.
Non bastava costruire un sacco e gettarci dentro tutti gli idiomi, così da evitare che “Far ridere i polli” diventasse “Make the chicken laugh”. Bisognava agire d’astuzia. Creare enormi basi di dati. Migliaia di regole a prova di ambiguità, dove l’eccezione diventasse il paradigma ad altre possibili anomalie.
Bisognava dare vita a un mostro più potente di Frankestein e più rapido di Super Man. Un sistema in grado di rendere logico un organo fluido e in continua evoluzione.
Soprattutto, bisognava lavorare sul significato.
È stato in quel momento che mi sono resa conto che la traduzione non può limitarsi a un punto di vista unico. Che la lingua, in generale, è agganciata in modo indissolubile alla gente che la parla. Come ci esprimiamo agisce sul nostro modo di pensare e viceversa.
Immaginate di parlare una lingua priva di genere per i sostantivi. Tutto ad un tratto, il mondo è piatto, perde una sfumatura essenziale di colore. Per i parlanti anglosassoni la cipolla, così bionda e femminile, diventa un semplice ortaggio neutro. E così il povero pomodoro.
Per quanto io mi sforzi di studiare l’inglese, avrò sempre una mente forgiata da una parlantina italiana. Quando mi esprimo in America, ci metto in media dieci minuti in più rispetto al mio interlocutore prima di arrivare al punto. Mi piace pianificare bene il discorso, dilungarmi sui dettagli.
Nel frattempo, l’altro tizio ha sbadigliato due o tre volte, compilato mentalmente la lista della spesa su un foglio Excel e pianificato le vacanze. Sembra il dialogo di un’enciclopedia logorroica con il Bignami che la riassume.
D’altronde la lingua inglese ha una preponderanza di parole monosillabiche, uno stimolo naturale a essere sintetici.
Quando ci rapportiamo a un’altra cultura, implicitamente cerchiamo di ritrovare un pezzo di noi stessi, un punto in comune. Ma ci sono differenze più o meno superficiali, che la traduzione coglie solo in parte.
Basti pensare alle forme di cortesia in italiano e in inglese. Al “Lei”, che quando provo a spiegarlo ottiene uno sguardo di totale sbigottimento: “Sì, dunque. In Italia per essere formali usiamo la terza persona. Femminile. Con il congiuntivo per le esortazioni…” Li avevo già persi al “formali”, al tentativo di chiarire quale sia il grado di confidenza che mi permette di non precipitare in incidenti diplomatici.
Ma è quando nomino il “congiuntivo” che mi accorgo di aprire una voragine senza ritorno. Un modo verbale quasi del tutto estinto in inglese e che fa l’effetto di un dinosauro spiaggiato, ricomparso dalla fantasia di Jurassic Park o dalla mente perversa di un italiano.
In fondo anche in Italia non è amato.
Forse bisognerebbe abolirlo in entrambe le lingue e non parlarne più. Un giorno verrebbe riesumato dalle profondità della terra, sedimentato in una pietra fossile insieme a un crostaceo e a delle foglie di Ginkgo Biloba, a imperitura memoria del suo passaggio nella storia.
E che dire delle parolacce? Si pensa che siano universali. Le si traduce in modo letterale, nel tentativo di mantenerne inalterata la forza espressiva. E invece, senza rendercene conto, creiamo scompiglio, offendiamo in modo irreparabile. In un batter d’occhio, si passa da un’atmosfera amichevole a una rissa da pub. Ci si ritrova afferrati dalle braccia di un omaccione tatuato e si dimenticano le sottigliezze della lingua.
Per qualche ragione, l’italiano tollera di buon grado un numero cospicuo di organi genitali e maiali.
Il “porco” diventa il capostipite di ogni esclamazione, colorandola di rosa. È talmente gettonato da abbinarsi in modo improbabile al cane, alla paletta, allo zio e a una serie variegata di concetti astratti e personaggi concreti.
Nella combinazione con “vacca”, l’inglese concede all’animale un salto di qualità. Da profano a sacro, da suino a santa: “Holy cow!”
Ora come vent’anni fa si ride alle spalle dei poveri programmi di traduzione automatica. Gli strafalcioni oltrepassano i limiti dell’assurdo, sconfinando nel ridicolo. Ci si indigna del fatto che un sistema informatico non sia in grado di ragionare come un cervello umano, neppure dopo la ricerca e gli investimenti nel settore. Rispetto a quando ci ho lavorato io, i risultati sono decisamente migliorati, eppure l’equivoco di base rimane inalterato.
Il programma NON è un sostituto dell’uomo. È il cugino scemo. Va preso per mano, e apprezzato per l’aiuto che può offrire. Se io non capisco il russo e voglio capire di cosa parla un sito internet, il traduttore digitale mi presenta un’idea approssimativa, anche se infarcita di qualche idiozia non richiesta.
In fondo, gli strumenti che ha a disposizione sono pochi: la grammatica, la statistica, o la più moderna strategia di Google che usa una “rete neurale”, un algoritmo di apprendimento che emula il funzionamento dei neuroni umani.
Ma la traduzione ha anche bisogno di empatia, conoscenza delle singole lingue e competenza interculturale.
Ha bisogno di capire il senso dell’umorismo, la battuta a fior di labbra, la provocazione dietro l’angolo.
Quando vedo che le parole mancano, i gesti mi vengono in soccorso. Sembro un mulino a vento, la faccia contorta in espressioni facciali che non sapevo neppure di poter produrre.
Forse il passo successivo sarà il ballo. Una musica che parte in sottofondo, io che mi agito e ammicco come sul palco di Bollywood. Forse.
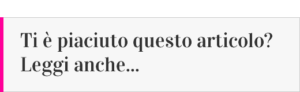
https://www.syndromemagazine.com/it/jesuisparis-cosa-hanno-pensato-i-tifosi-del-psg-dopo-la-sconfitta-della-champions-league/
[:]


Xavier
Pezzo interessante e piacevolmente ironico. Ci sono arrivato per caso, digitando nel motore di ricerca: “perché il traduttore di Google usa la forma di cortesia per default ? Se scrivo “tu” in francese mi traduce “vous” e questo anche in spagnolo. Non c’è modo di aggirare la cosa ?” Giro la stessa domanda qui, un po’ alla portoghese ?☺.
Grazie in ogni caso.
Xavier