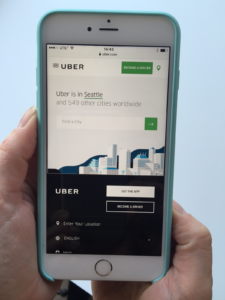 Cos’è un UBER se non un tuffo nel cuore pulsante dell’umanità?
Cos’è un UBER se non un tuffo nel cuore pulsante dell’umanità?
Una corsa in automobile non è più un tragitto da un punto di partenza a una meta, ma una vera occasione sociale.
Ve lo garantisce una persona che, per i primi mesi in America, ha avuto il terrore di imboccare l’autostrada e, per necessità, ne ha preso qualcuno.
 Innanzitutto vorrei far luce su una questione: io so guidare. Con la personalità tipica degli animi inquieti, quasi ottocenteschi: guido come un cocchiere in carrozza, con quattro cavalli recalcitranti da governare. Ma guido.
Innanzitutto vorrei far luce su una questione: io so guidare. Con la personalità tipica degli animi inquieti, quasi ottocenteschi: guido come un cocchiere in carrozza, con quattro cavalli recalcitranti da governare. Ma guido.
Lo dimostra non solo la patente italiana da cui, a più riprese, ho perso qualche punto (ma è pur sempre lì, nel portafoglio, a riprova del fatto che esiste), ma anche quella nuova di zecca americana. Una tesserina di plastica che mi è costata lacrime e sudore, due notti insonni e irripetibili pensieri di vendetta ai danni dell’esaminatore della prova pratica.
 Giustamente, negli Stati Uniti non si fidano delle abilità al volante dei nuovi arrivati. Sanno che le regole sono un limite alla creatività e che alcuni paesi preferiscono l’interpretazione libera piuttosto che la monotonia della ripetizione.
Giustamente, negli Stati Uniti non si fidano delle abilità al volante dei nuovi arrivati. Sanno che le regole sono un limite alla creatività e che alcuni paesi preferiscono l’interpretazione libera piuttosto che la monotonia della ripetizione.
Con la residenza permanente, scatta l’obbligo di ridare l’esame.
Così accade che il passato torna d’un tratto a bussare alla tua porta, facendo riaffiorare ricordi che avresti voluto seppellire: non solo il mal di pancia che precede il test, i gorgoglii che rimestano le profondità dello stomaco e prorompono in momenti inappropriati, ma la fraseologia del motore, una serie di codici dove noia e tedio si sfidano a duello per gareggiare contro l’uggia.
Ma è sul campo che le abilità vengono davvero testate.
 Le strade dell’Eastside hanno un ritmo lento, grandi corsie e automobilisti rispettabili che procedono a un passo da villeggiatura, quella che consente, con un po’ di esercizio, di sorseggiare il caffè al volante o cantare a squarciagola imitando il cantante alla radio.
Le strade dell’Eastside hanno un ritmo lento, grandi corsie e automobilisti rispettabili che procedono a un passo da villeggiatura, quella che consente, con un po’ di esercizio, di sorseggiare il caffè al volante o cantare a squarciagola imitando il cantante alla radio.
Nessuno ti mette fretta perché la fretta è un concetto alieno, forse europeo, che implica una negatività di cui la gente è priva. Mai visto nessuno che estraesse il dito medio a un incrocio, ad esempio. Credo che, se avvenisse, lo shock sarebbe talmente grande da fermare il traffico all’istante. Ci sarebbero immediati “case studies” per analizzare l’uso semiotico del dito, la necessità comunicativa di puntarlo al cielo. Probabilmente la conclusione sarebbe che era un movimento involontario dettato da una contrazione muscolare, e il traffico riprenderebbe normalmente.
 Tanto è tranquillo il percorso lungo le vie dei suburbs, quanto è frenetico quando si accede a un’autostrada. Il problema è che avviene senza preavviso: non ci sono caselli o indicazioni più specifiche di un misero numeretto (la 405, la 90, la 705…).
Tanto è tranquillo il percorso lungo le vie dei suburbs, quanto è frenetico quando si accede a un’autostrada. Il problema è che avviene senza preavviso: non ci sono caselli o indicazioni più specifiche di un misero numeretto (la 405, la 90, la 705…).
Per chi, come me, è poco pratico della geografia locale, e si affida interamente al navigatore satellitare, il passaggio ha l’effetto di una secchiata di acqua gelida. Mentre fino a un minuto prima guidavi con la soglia di attenzione di un gatto accoccolato sul divano, all’improvviso hai bisogno di un paio di occhi roteanti per osservare le decine di macchine che sfrecciano da ogni parte, sorpassandoti a destra e a sinistra indifferentemente. La velocità dev’essere aumentata di colpo e poi mantenuta costante, le pupille focalizzate sui rallentamenti in lontananza, le dita dei piedi frementi sul freno. Inutile dire che i neuroni impegnati in una tale faccenda sono innumerevoli e senz’altro superiori a quelli in mia dotazione.
 C’è un punto famigerato a Seattle, al termine del ponte sul lago Washington, dove si devono attraversare cinque corsie nel giro di poche decine di metri, da quella più a sinistra dove si era stati catapultati a quella più a destra dove c’è l’uscita verso la città.
C’è un punto famigerato a Seattle, al termine del ponte sul lago Washington, dove si devono attraversare cinque corsie nel giro di poche decine di metri, da quella più a sinistra dove si era stati catapultati a quella più a destra dove c’è l’uscita verso la città.
Ogni volta che mi ci avvicino, stringo le labbra e vado in apnea.
Oltre alla freccia, utilizzo ogni strumento in mio potere per segnalare alle macchine dietro e di fianco il mio attraversamento, dal finestrino aperto, allo scambio vocale, al gesticolare folle. Gli automobilisti a volte suonano il clacson, che equivale a dire che devo veramente averli tirati fuori dai gangheri. Prima non sapevano neppure di avere un clacson.
Vista la premessa, Uber si è profilato come un’ancora di salvezza, un meraviglioso antidoto allo stress.
Ciò che ancora non sapevo era che, oltre allo spostamento fisico, mi avrebbe concesso un viaggio mentale pari all’amplificazione lucida di coscienza.
L’azienda di trasporto automobilistico, decretata illegale in Italia dal 2015, fa parte del fenomeno definito da qualcuno più saggio di me “gig economy”, il modello economico che si basa su prestazioni lavorative temporanee, facilitate dall’uso della tecnologia. Un lavoro occasionale, spesso affiancato a un’altra attività o allo studio, che consente maggiore flessibilità e un’integrazione di introiti settimanali, ma anche meno tutele sociali.
Su una macchina Uber, puoi incontrare la selezione più sorprendente di individui, senza filtri di alcun genere.
 Puoi incontrare Caleb, ad esempio. Un signore brizzolato sulla cinquantina, con un mento prominente e occhi scavati da stregone. Appassionato di linguistica giapponese, parlava dei logogrammi kanji come se fossero piccole deliziose creature del regno fatato.
Puoi incontrare Caleb, ad esempio. Un signore brizzolato sulla cinquantina, con un mento prominente e occhi scavati da stregone. Appassionato di linguistica giapponese, parlava dei logogrammi kanji come se fossero piccole deliziose creature del regno fatato.
Aveva trovato pane per i sui denti. La grammatica per me racchiude i misteri dell’universo. Ricordo ancora un articolo universitario intitolato “La morte del pronome”, un argomento che avrebbe suscitato commozione anche tra i più insensibili. Pensando di fargli cosa gradita, l’ho menzionato, ma invece di ricevere una pacca solidale sulla spalla, la notizia sembrava lasciarlo del tutto indifferente: il pronome italiano poteva tranquillamente morire di stenti e sofferenze indicibili a patto che quello del Sol Levante godesse di ottima salute.
Il problema era che, mentre le parole Man’yōgana, Hiragana e Katakana, frullavano in un battito d’ali nell’abitacolo del veicolo, Caleb si è perso l’uscita dell’autostrada. Così, abbiamo trascorso un’altra mezz’ora intasati nel traffico a parlare dei suoi amici del bosco Kanji.
Grazie al cielo il prezzo delle corse è preimpostato.
 Oppure puoi incontrare Piper, mamma single e architetto. Col bambino più virtuoso nella storia dell’infanzia, a giudicare dai suoi racconti. A nove anni, Connor l’aiutava in casa, portava il cane a passeggio, faceva i compiti, prendeva ottimi voti, ogni giorno tornava soddisfatto da scuola con una praise note, il bigliettino che gli insegnanti danno agli alunni in riconoscimento di comportamenti notevoli.
Oppure puoi incontrare Piper, mamma single e architetto. Col bambino più virtuoso nella storia dell’infanzia, a giudicare dai suoi racconti. A nove anni, Connor l’aiutava in casa, portava il cane a passeggio, faceva i compiti, prendeva ottimi voti, ogni giorno tornava soddisfatto da scuola con una praise note, il bigliettino che gli insegnanti danno agli alunni in riconoscimento di comportamenti notevoli.
“E sa persino stirare!” Mi ha detto raggiante.
Non so perché, ma Connor non mi stava per niente simpatico. Lo immaginavo occhialuto e lentigginoso, con una vocina stridula e un pigiama orrendo.
Su Uber trovi gli americani veri. Che scopri essere di tutt’altra provenienza, in realtà. Quelli che con orgoglio ti dicono: “Anch’io sono italiano!” perché sono cresciuti a Brooklyn, o quelli col nonno vietnamita, la madre russa, il padre slovacco e il cugino del New Jersey.
E per ognuno di loro c’è una storia, l’orgoglio delle origini, il legame con una terra mitica mai vista.
 Oppure incontri gente da ogni luogo, arrivati da poco o trapiantati da anni, come Caterina, che non tornava in Romania da vent’anni: qui era nata sua figlia e qui aveva appena seppellito il marito dopo un infarto.
Oppure incontri gente da ogni luogo, arrivati da poco o trapiantati da anni, come Caterina, che non tornava in Romania da vent’anni: qui era nata sua figlia e qui aveva appena seppellito il marito dopo un infarto.
Ricordo che ha tirato su col naso, gli occhi umidi sotto una cascata di riccioli cotonati. Mi ha guardato dallo specchietto retrovisore e mi ha detto: “Ah, l’America! Ci vieni per poco e non la lasci più”.
Io ho avuto un brivido da grande profezia di Celestino. Poi ho iniziato a fare gesti scaramantici meccanicamente, come se la mia mente razionale lottasse tra ansia e superstizione. Non perché non mi piaccia l’America, che invece trovo sempre più intrigante. Ma perché la frase era caduta con un tonfo che sapeva di definitivo.
Lì per lì mi è balenata l’idea che ciò che chiamiamo “casa” sia uno strano intreccio di circostanze, ma soprattutto il risultato di una collezione di momenti significativi. E che Caterina li aveva vissuti proprio tutti.
Il più avvincente è stato Ramón, comunque. Di genitori cubani, nato e cresciuto a New York, trasferitosi a Seattle da pochi anni. Di Cuba gli era rimasto il nome, la lingua e uno scoppiettante rimescolio di amore e odio indiretto, filtrato dalle generazioni precedenti. A tratti esordiva con risate immotivate, che per i primi cinque minuti ho sospettato avessero me come oggetto. Dopo un po’ lo scroscio è diventato contagioso: la macchina si è tinta di sole cubano e mi sono ritrovata a ridere senza sapere perché.
Sugli Uber di Seattle c’è sempre tempo per una chiacchierata, tra una goccia e l’altra di pioggia.
Quando si apre la portiera, sembra di entrare in un salotto.
E quest’America, fatta di incontri ripescati dal cilindro del caso, ha il fascino accessibile di una scampagnata tra amici.[:it]


Leave a Reply