Devo seriamente cominciare a studiare.
Non si può vivere a Seattle senza conoscere le regole del football americano.
Sono qui da qualche mese ormai e non ho ancora capito niente.
Il football è l’oggetto principale di conversazione, persino più del tempo che, con le piogge torrenziali al mattino e le schiarite repentine nel pomeriggio, offrirebbe già notevoli spunti. Su quello mi sentirei decisamente più preparata.
Potrei offrire il mio parere sulle tonalità di grigio, paragonarle alle tinte italiane, testare l’umidità con un dito o fiutare le correnti del vento.
 Sul tempo c’è sempre qualcosa da dire. Ci si può lamentare o rallegrare per una nuvola di passaggio. Si può persino fare qualche ipotesi empirica: che Christian GREY sia di Seattle, e GREY’s Anatomy sia ambientata qui non sarà mica un fatto casuale. GREY, sembra un indizio piuttosto inequivocabile.
Sul tempo c’è sempre qualcosa da dire. Ci si può lamentare o rallegrare per una nuvola di passaggio. Si può persino fare qualche ipotesi empirica: che Christian GREY sia di Seattle, e GREY’s Anatomy sia ambientata qui non sarà mica un fatto casuale. GREY, sembra un indizio piuttosto inequivocabile.
Invece mi ritrovo spesso in conversazioni dove l’unico contributo che posso dare è annuire con aria pensosa. Sorrido se c’è da sorridere o mi acciglio se il tono vira verso una dimensione di gravità. In questo mi rallegro che i miei neuroni a specchio siano perfettamente efficienti, consentendomi di sostenere il mio interlocutore con le stesse espressioni facciali.
Ma dietro a quei gesti non c’è altro che il nulla. Una landa desolata di termini che non fanno squillare nessun campanello, nomi di giocatori che non risvegliano alcuna associazione visiva.
Nel tempo ho acquisito qualche nozione di base in modo del tutto passivo, un po’ come quando la gomma da masticare ti si appiccica sotto le scarpe tuo malgrado.
 Tra queste la prima e fondamentale: i Seattle Seahawks sono la squadra locale. Ho letto stasera su Wikipedia che sono nati nel 1975, come me, e questo presupporrebbe una certa affinità, che però colgo solo a sprazzi.
Tra queste la prima e fondamentale: i Seattle Seahawks sono la squadra locale. Ho letto stasera su Wikipedia che sono nati nel 1975, come me, e questo presupporrebbe una certa affinità, che però colgo solo a sprazzi.
Sono rappresentati dall’effigie dell’aquila e dai colori blu, grigio e verde e riveriti come un’incarnazione divina, cosa che a me non capita.
 I loro tifosi sono rappresentati collettivamente dal numero “12”, il dodicesimo uomo, e sono conosciuti per essere tra i più rumorosi del mondo. Anche la mia famiglia potrebbe vantare un risultato analogo.
I loro tifosi sono rappresentati collettivamente dal numero “12”, il dodicesimo uomo, e sono conosciuti per essere tra i più rumorosi del mondo. Anche la mia famiglia potrebbe vantare un risultato analogo.
Nel settore, ho letto che detengono un vero e proprio primato. La notizia mi ha immediatamente incuriosita.
Come si misura una caratteristica del genere? Esiste un’apparecchiatura sofisticata che coglie le onde sonore legate ai coretti da stadio? Come ne determinerà le frequenze in relazione agli altri stadi del mondo? E che nome avrà uno strumento del genere? Il “fischiettometro”?
 Non è raro vedere la bandiera della squadra affiancare quella a stelle e strisce di fronte alle villette dei suburbs.
Non è raro vedere la bandiera della squadra affiancare quella a stelle e strisce di fronte alle villette dei suburbs.
Perché in America il patriottismo è importante, ma lo sport ha una dimensione più tangibile, stimola i sentimenti di lealtà con un pulsante istantaneo.
 Ogni città ha la propria squadra, che è unica e identificabile. Così si evitano i derby, una specie di lotta civile senza fine.
Ogni città ha la propria squadra, che è unica e identificabile. Così si evitano i derby, una specie di lotta civile senza fine.
La squadra del cuore è esibita con tale orgoglio che persino alcune case di legno sono dipinte con i colori appropriati, o con una gigantografia del logo in bella mostra sulla porta dei garage.
 Durante il periodo natalizio, l’entusiasmo si tinge di luci.
Durante il periodo natalizio, l’entusiasmo si tinge di luci.
A pochi passi da casa mia un’abitazione si illumina di 150.000 lampadine e mostra un’aquila di 10 metri lungo la cresta del tetto. La gente può andare a visitarla, sostenendo il proprietario per ripagare la bolletta dell’elettricità.
Sono manifestazioni eccessive? Può darsi. Ma in fondo penso che preferisco un’esplosione di luminarie a una rissa sotto il balcone.
Il mio limite maggiore resta la partecipazione, esattamente come in Italia.
In realtà mi piacerebbe molto provare le stesse emozioni del tifoso, passare dalla disperazione alla gioia, rinvigorita dalla speranza di un gol. Vorrei intonare una canzone con la mano sul cuore, sentirmi parte del tutto.
Invece le traiettorie della palla si confondono alla lista della spesa o all’agenda della settimana, dalle melanzane per la pasta all’appuntamento del dentista. È come se la mia mente preferisse seguirne le evoluzioni in una realtà parallela invece che soffermarsi sul presente.
Devo ammettere che per questo, ultimamente, mi sento spaesata. Sono finita nel regno dello sport.
 A me l’America era nota per l’obesità dei suoi abitanti. Me l’aveva detto Michelle Obama in persona dallo schermo televisivo.
A me l’America era nota per l’obesità dei suoi abitanti. Me l’aveva detto Michelle Obama in persona dallo schermo televisivo.
Arrivavo armata della mia dieta mediterranea, io e le mie zuppette di verdura, con un filo d’olio d’oliva e una spruzzatina di parmigiano.
E che dire dei miei allenamenti settimanali di Pilates? Per anni avevo tirato e ritirato i legamenti, diventando più snodata di una Barbie.
Che poi alle zuppette alternassi gli antipasti alla piemontese e alle sessioni in palestra i bivacchi sul divano, mi pareva cosa di poco conto. Una mezza virtù è meglio del vizio nella sua interezza.
 Nell’East side di Seattle, invece, sono tutti salutisti. Non solo pasteggiano a forza di intrugli proteici, ma corrono senza sosta con cani e passeggini. Indossano le maglie dei Seahawks per andare al lavoro, conoscono le regole di TUTTI gli sport.
Nell’East side di Seattle, invece, sono tutti salutisti. Non solo pasteggiano a forza di intrugli proteici, ma corrono senza sosta con cani e passeggini. Indossano le maglie dei Seahawks per andare al lavoro, conoscono le regole di TUTTI gli sport.
Persino il frisbee, nella versione locale di Ultimate Frisbee, è assurto ai ranghi di sport di squadra, tanto da essere proposto alle prossime Olimpiadi. Sarebbe come se da noi volessero portarci il Gioco della Settimana.
Qualche mese fa avevo accompagnato mia figlia a una festa di compleanno. Credevo sarebbe stata una buona occasione per conoscere i genitori della classe. In realtà ho realizzato nel momento in cui ho varcato la porta che la presenza dei genitori era del tutto superflua. Non solo, i bambini erano scaricati come bombe sul procinto di esplodere e lasciati al loro destino. Mi sono ritrovata con l’unico genitore presente in un silenzio imbarazzato, spremendo le meningi alla ricerca di un argomento.
Ci ha pensato lui.
Per un’ora e mezza ho ascoltato a bocca aperta tutte le peripezie sportive di questo papà, un vero esperto sia nella teoria che nella pratica. Aveva provato tutto: dalla maratona al triathlon, dal canottaggio al baseball, dal basket alle gare di bicicletta. Mancava solo il surf sulle sabbie mobili. Con la ciliegina del football americano, in cui ho esibito la stessa faccia assorta di un ciottolo da fiume.
Alla fine del racconto ero esausta. Anche annuire per un’ora e mezza potrebbe essere considerato uno sport estremo.
Ma il momento terribile è stato quando al semplice resoconto è subentrata la domanda.
“E tu? Quale sport pratichi?”
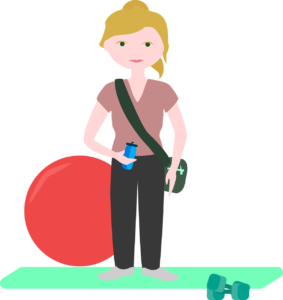 E lì mi sono resa conto che qualunque risposta l’avrebbe lasciato insoddisfatto. Che rispondere “il pilates” l’avrebbe deluso come un poeta privato dell’ispirazione.
E lì mi sono resa conto che qualunque risposta l’avrebbe lasciato insoddisfatto. Che rispondere “il pilates” l’avrebbe deluso come un poeta privato dell’ispirazione.
Così sono fuggita. Di nascosto.
Ho soffiato sulle candeline e ho tirato mia figlia per la manica della camicia.
Vorrei farmi due chiacchiere con l’Ironia della Sorte. O l’Ironia e la Sorte. Amiche di vecchia data, me le immagino spaparanzate sul divano, che osservano le mie peripezie dallo schermo di una TV a 42 pollici. La Sorte mi ha portata negli Stati Uniti, l’Ironia ha scelto di farmi trovare solo leggins in tessuto tecnico nelle vetrine dei negozi.
La Sorte mi ha dato in dono una famiglia. L’Ironia li ha dotati di geni che li rendono propensi al fanatismo sportivo. Per amore ho iniziato a seguire le partite di rugby, a osservare per ore le figurine dei calciatori imparandone dettagli quasi intimi, a rivedere canestri di basket su Youtube in loop infiniti.
 E le mie belle scarpe coi tacchi? Quelle che la Sorte mi aveva fatto trovare in un negozietto nascosto di Torino?
E le mie belle scarpe coi tacchi? Quelle che la Sorte mi aveva fatto trovare in un negozietto nascosto di Torino?
L’Ironia le ha sostituite con delle scarpe da ginnastica.
Perché anch’io, finalmente, ho cominciato il mio percorso di cambiamento. E vado in palestra. A sudare.
Il mio istruttore è orgoglioso dei miei progressi. E ogni volta penso che, effettivamente, dovrebbe pagarmi per metterli in atto.
[:]


Leave a Reply